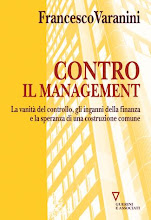L'articolo di Claudio Baccarani scritto a commento di Contro il management, "Contro il management, per una costruzione
comune alla ricerca dell’impresa armonica", è apparso sulla rivista Sinergie, 83/10.
Claudio Baccarani, Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso l'Università degli Studi di Verona, commenta acutamente le tesi sostenute nel libro. Per arrivare infine a dire: "dato che leggendo le sue pagine mi sono rifatto un’idea, visto che ci sono la
trascrivo evitando categoricamente di tirare in ballo la delicata parola scienza: il
Management è l’arte della produzione di fiducia e della costruzione del futuro
desiderato nel contesto del governo dell’impresa.
Che bello sarebbe poterne discutere".
Trovate qui l'articolo.
Visualizzazione post con etichetta Business Ethics. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Business Ethics. Mostra tutti i post
domenica 6 dicembre 2015
lunedì 14 novembre 2011
Perché dovremmo fidarci di un tecnico? E in special modo, perché dovremmo fidarci di un tecnico bocconiano?
Comunque la si metta, Monti è un
‘tecnico’. Vorrei non dimenticassimo che ‘tecnico’ è un
altro modo per dire ‘manager’. Ricordiamo che nella nostra
lingua fino agli anni sessanta si diceva ‘tecnico’ per intendere
ciò che oggi chiamiamo ‘manager’. La domanda è: possiamo
fidarci dei manager? Riuscirà un gruppo di manager a fare ciò che
non ha saputo fare un’intera classe politica? Spero di sì, e penso
che la decisione del Presidente Napolitano sia stata una buona
decisione.
Ma in questo momento diventa
specialmente importante riflettere sul ruolo del manager.
Ho scritto questo libro, Contro il
management, per mettere in guardia di fronte alle malefatte e
alla pericolosità dei manager. Ho anche detto -e ne sono ancora
convinto- che, così come siamo pronti a dire subito dei difetti e
dell’inaffidabilità dei politici di professione, altrettanto, ed
anzi di più, dovremmo imparare a diffidare dei manager.
Eppure, diamo il benvenuto a Monti. Non
solo perché la situazione di stallo non vedeva molte altre soluzioni
ragionevoli. Non solo perché il nostro stare nel mondo richiedeva
rappresentanti in grado di non ledere la nostra immagine, e la nostra
stessa dignità. Non solo perché serviva qualcuno in grado di
‘metterci la faccia’, serviva qualcuno che potesse essere
riconosciuto come interlocutore autorevole, di fronte ai leader
politici stranieri, di fronte ai fin troppo nominati e rispettati
‘mercati’.
Diamo il benvenuto a Monti perché il
manager può essere veramente la figura che serve, qui ed ora.
Possiamo ricordare che -come mostro in
Contro il management-
questa figura di tecnico, chiamato a gestire organizzazioni
complesse, è venuta alla luce negli anni ‘30 del secolo scorso,
come risposta alla crisi di allora. Credo che si possa dire che le
risposte, allora, furono date, sotto molti aspetti, in modo più
fermo e preciso di quanto sia stato fatto ai nostri giorni, di fronte
a una crisi che non è meno grave.
L’ora dei tecnici
Il manager emerse allora come figura
‘laica’, indipendente da ogni portatore di interessi. Di fronte
all’eccessivo prevalere di un interesse su un altro, serve un
tecnico che gestisca il potere contemperando i diversi interessi. Una
figura sociale in grado di trovare, e di imporre a tutti, un
ragionevole punto di incontro tra i diversi interessi. Pensiamo al
prevalere dell’interesse della speculazione finanziaria rispetto
all’interesse dei ceti produttivi; pensiamo ai divergenti interessi
di giovani alla ricerca di lavoro e di anziani attenti alla pensione;
pensiamo al conflitto tra chi paga le tasse e chi non le paga;
pensiamo all’opposizione tra orientamenti centralistici e la
tendenza ad incrementare le autonomie locali; pensiamo all’allargarsi
del divario tra ricchi e poveri; alla perdurante distanza tra Nord e
Sud.
Certo, il senso del limite, della
misura, del bene comune, dell’interesse collettivo, dovrebbe far
parte del bagaglio di ognuno. Certo, dovremmo, e potremmo essere
capaci, discutendo in pubblico -questa è in fondo la democrazia:
discussione in pubblico- dovremmo essere capaci di trovare un punto
di incontro, di equilibrio, un’area di convergenza. Ma intanto,
prima che la casa comune sia irreparabilmente danneggiata, bisogna
fare qualcosa. Ecco che si rende necessario ricorrere al manager. La
storia non si ripete, ma ricordiamo che negli anni ‘30 dove
fallirono i manager vinsero le dittature.
Di una simile figura, oggi abbiamo
bisogno. Il lavoro del manager si riassume in questo: scontentare
ogni interesse di parte in funzione dell’interesse collettivo.
Precisamente ciò che non riescono a fare -ed anzi, in fondo non
possono fare- i partiti politici. I partiti, per quanto allarghino la
propria base sociale, nascono appunto per rappresentare alcuni
interessi, e non altri.
Questo ragionamento porta a riflettere
sul complessivo senso della politica e della democrazia. Ma non
allarghiamoci. Badiamo a fare qualcosa che serva adesso, senza
perdere tempo. Ricordiamo che per il manager, in fondo, vale il
detto: ‘non importa di che colore è il gatto, basta che prenda i
topi’.
Il ‘topi da prendere’ possono
essere riassunti in tre parole: crescita, responsabilità,
equità.
Crescita, responsabilità, equità
Però la prima parola, crescita,
a guardar bene non ci serve a nulla, ed è fin pericolosa. Tramontata
l’illusione che voleva la ricchezza di pochi fonte di vantaggio per
tutti, risulta necessario precisare di che crescita si tratta. E’
crescita anche la crescita della diseguaglianza e dell’ingiustizia.
Dovremmo quindi dire: crescita come, crescita per chi, crescita
quando, crescita dove.
Perciò, di tutto ciò che va dicendo
Monti, restano due parole: responsabilità ed equità.
Guardiamo dunque alla responsabilità.
La parola è stata ultimamente abusata e sbeffeggiata, la si è
costretta a dire il contrario di ciò che essa vuol dire.
Responsabile è colui che rinuncia all’interesse di parte in
funzione dell’interesse collettivo, colui che manifesta
solidarietà, colui che non svende il futuro in cambio del presente,
colui che non antepone il proprio personale vantaggio al bene comune.
Quindi agiscono in modo non
responsabile i politici che sostengono governi privi di progettualità
e asserviti alla difesa di interessi di parte. E altrettanto,
agiscono in modo non responsabile quei manager che asservono le
imprese al prevalere di un interesse su tutti gli altri: caso tipico,
di questi tempi, i manager che si sentono al servizio dell’azionista
o magari dello speculatore di borsa, ma non altrettanto al servizio
dei lavoratori dell’impresa da loro diretta, dei clienti, dei
fornitori, di coloro che vivranno in futuro dell’impresa, se questa
non sarà schiacciata da interessi di breve periodo.
E ancora, non sono responsabili coloro
-e sono molti- sostengono che l’Italia non deve pagare il proprio
debito. Dicono: se dall'altra parte c’è un ladro, non c’è
debito nei suoi confronti. Dicono ancora: quel debito non l’abbiamo
contratto noi, quindi noi non paghiamo. Ma esportare la colpa,
dipingendo l’altro come la fonte del male, è un tipico meccanismo
di fuga. Dovremmo invece pensare -senza per questo dimenticare le
colpe più gravi e le ingiustizie che abbiamo sotto gli occhi-
dovremmo pensare che sì, ognuno di noi è stato causa di quanto è
accaduto. Abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità,
abbiamo goduto di situazioni di comodo. A tutti compete contribuire
a trovare una praticabile via d’uscita. I nostri creditori non sono
solo avidi speculatori, ma sono anche persone come noi che hanno
prestato denaro al nostro paese. Se i padri compiono errori, sta ai
figli ripararli – nel proprio interesse. L’indignazione ha senso
se si risolve in azione. Non si vive di sola opposizione. Non si vive
senza una classe dirigente. Infatti, alla fine si ricorre ai manager.
L’altra parola, che speriamo Monti
non dimentichi strada facendo, è equità. Appunto,
scontentare tutti negli interesse di tutti. Cercare un punto di
incontro, un’area di convergenza in nome di tutti gli interessi in
gioco. Anche degli interessi di chi non ha voce.
Per questo serve, più della competenza
tecnica, un atteggiamento etico. Più che razionalità, serve
saggezza.
I bocconiani
Questo è il punto chiave: perché
dovremmo fidarci di un tecnico? E in special modo, perché dovremmo
fidarci di un tecnico bocconiano?
In Contro il management ho
argomentato, spero in modo abbastanza convincente, contro i tecnici
bocconiani. Mi esprimo in termini generali e faccio appello alla
saggezza. Quindi non vale la difesa del tipo ‘io sono diverso’.
Riflettano i bocconiani su uno scivolamento che ha caratterizzato la
loro scuola: si sono allontanati dalla lezione di Gino Zappa, che
incarnava una tradizione italiana, legata al nostro modo di fare
impresa, legata all’idea di azienda come luogo di incontro e di
temperamento dei diversi interessi in gioco. Hanno trascurato questa
tradizione per divenire gli ambasciatori nel nostro paese del
management di marca statunitense. Che nascondeva in sé l’inganno e
il non detto: esistono diversi interessi in gioco, ma un interesse
vale più degli altri. Il profitto prevale sulla remunerazione del
lavoro. La Bocconi e la Sda si sono fatti vanto di inserire l’Italia
nel quadro del capitalismo anglosassone. Il neoliberismo, ed il
governo dell’impresa che si inserisce in questo quadro, sono state
il vanto dell’università e della business school. Ma queste regole
e questo governo hanno contribuito alla nostra rovina tanto quanto, o
forse più, dell'insipienza della nostra classe politica. Per questa
via, alla fin fine, l’interesse della finanza speculativa ha finito
per prevalere in modo smaccato su ogni altro interesse.
Cosa possiamo aspettarci
Dobbiamo dunque sperare che Monti
riesca a prescindere da questa tradizione, da questa scuola.
L’orgoglio dell’essere italiani, il recupero della nostra
reputazione e della nostra stessa dignità non stanno nell’essere
uguali agli altri. In nostro futuro non può emergere da scuole ed
università i cui insegnamenti finiscono per legittimare e favorire
il prevalere dell’interesse finanziario. Essere ben piazzati in
certe classifiche che mettono in fila università e business school
di ogni dove, dovrebbe essere inteso più come difetto che come
pregio. Quei manager fatti con lo stampino che escono dalla Bocconi e
dalla Sda con il massimo dei voti e con le migliori opportunità di
impiego, non sono certo i manager che possono portarci fuori dalla
crisi.
Dunque: Monti non è solo il male
minore. Abbiamo buoni motivi per fidarci di lui. Ne sono prova il
lavoro svolto in Europa, la sua lucidità, la sua esperienza, la sua
saggezza.
Da lui ci aspettiamo molto. Ci
aspettiamo che mantenga la promessa contenuta nella terza delle
parole sopra ricordate: l’equità. L’equità non si fonda
su assiomi o su scelte di campo, non sta in nessun programma.
L’equità sta nel fare per noi ciò che non abbiamo saputo fino ad
ora fare: guardare al bene comune, oltre ogni privato e personale e
immediato interesse. L’equità sta in un progetto perseguito
giorno dopo giorno, passo dopo passo, nel pubblico confronto e nel
rispetto dell’altro. Questo è il ruolo del manager, questo ci
aspettiamo da Monti.
Perciò dobbiamo sperare che Monti si
mantenga lontano da ogni appartenenza e dalla sua stessa scuola e dal
suo stesso passato. Speriamo si dimostri saggio, indipendente, fermo
e dialogante. Speriamo sia il meno possibile bocconiano.
Etichette:
Business Ethics,
Management vs. politica
mercoledì 29 dicembre 2010
La finanza narrata. Romanzi classici e romanzi possibili
Ho ritrovato uno scritto del 1999.
Lì citavo Balzac e la sua Parigi e il suo tempo. In particolar modo, credo, avevo in mente Illusions perdues (1843).
Scrivevo:
La società è una palestra di interessi economici: tutti vi siamo implicati, si vale solo se si riesce ad imporsi. "Il successo è divenuto il principio supremo di un'epoca atea", il sigillo dei tempi nuovi, sia in industria che in economia arte e spirito. Si assiste al "dilagare della finanza". Non è più possibile distinguere un commerciante da un pari di Francia; il nuovo titolo di nobiltà nella della società moderna è l'essere "il più tassato di tutto il circondario". Politica amore e arte sono diretti dal denaro. La produzione in serie distrugge il valore artistico e artigianale del lavoro: "nous avons des produits, nous n'avons plus d'oeuvres". Non conta più "l'energia isolata, ricca di creazioni originali", conta invece "l'energia uniforme, ma livellatrice, che parifica i prodotti, li produce in massa, obbedendo a una idea unitaria".
In Contro il Management cito Zola, L’Argent (1891). Sono passati cinquant'anni, lo scenario si è evoluto, ma gli elementi di fondo del quadro non è cambiato. La pressione della finanza è sempre più evidente. La Borsa -già intesa nel 1808 da Napoleone, quando pose la prima pietra del palazzo che doveva ospitarla, come "le thermomètre de la confiance publique"- è l'ombelico del mondo fondato sulla finanza.
Si completa il disegno già descritto da Balzac, un disegno sociale economico, ma anche di pianificazione urbanistica e territoriale. Le fabbriche stanno in periferia, in provincia. Il centro della metropoli, invece, si identifica con la finanza, ed il suo luogo simbolico: la Borsa. Ecco la Parigi di Napoleone III nel 1867, alla vigilia dell'Exposition Universelle, freneticamente attiva, assordata dal rumore dei cantieri aperti dal prefetto Haussmann, che sventra la città e la rimodella come moderno salotto di boulevard e gallerie commerciali. E al centro, qui, come in quegli stessi anni a Londra e a New York, la Borsa.
La speculazione finanziaria si sostituisce al lavoro. Rappresenta in forma semplificata ed estrema “l'eterno desiderio che spinge a lottare e a vivere”. “Un grande sogno, da un soldo ricavarne cento”. Zola, nel romanzo L'Argent, ci descrive meglio di qualsiasi economista, di qualsiasi storico o sociologo il significato sociale di questo luogo: frastuono spaventoso, continuo gesticolare degli agenti, “danzante mimica dei corpi, quasi pronti a divorarsi reciprocamente”, trionfi, crolli, speranze, duri dati di realtà. Aristide Saccard, protagonista romanzo “è veramente il poeta del milione”. “I suoi figli, le sue donne, insomma tutto ciò che lo circonda, viene per lui dopo il denaro”. “Non era forse, il denaro, e soltanto il denaro, la forza che può spianare una montagna, colmare un braccio di mare, rendere la terra finalmente abitabile per gli uomini, liberati dal giogo del lavoro che abbruttisce, facendoli diventare conduttori di macchine?”.
Come sostengo in altri miei libri, e anche in Contro il management, nessun sociologo, nessuno storico, nessuno studioso di discipline economiche e aziendalistiche sa descrivere il mondo della fianza e dell'impresa come sanno fare i romanzieri. Quindi, anche se non mi viene in mente al momento nessun romanzo contemporaneo comparabile con Le illusioni perdute e Denaro, credo che né Balzac ne Zola siano eccezioni. Quello che è certo è che il materiale romanzesco non manca.
Bastano due esempi. Il primo: una notizia apparsa di recente sulla stampa parla del nuovo investimento della Deutsche Bank. Cito da Repubblica del 17 dicembre 2010: la Deutsche Bank, la più forte, moderna e globale banca d' affari tedesca, ha appena aperto un gigantesco casinò di superlusso, con annesso hotel, a Las Vegas. The Cosmopolitan, si chiama la nuova super-casa da gioco voluta dai signori della finanza di Francoforte.
Hanno investito 4 miliardi di dollari per realizzare l' enorme grattacielo, un nuovo simbolo della metropoli del gioco d' azzardo. Ben 83 tavoli da gioco, 1474 slot machines di ogni genere,e tremila tra cameree suites. Deutsche Bank si mostra come sempre sicura di aver fatto centro: alla fine, tra i tanti giocatori d' azzardo che saranno suoi ospiti, qualcuno vincerà alla roulette, al poker o alle slot machines, ma alla fine i grandi profitti li realizzerà il colosso finanziario. La certezza di non aver sbagliato è tanta che gli spot pubblicitari per l' apertura mostrano signore mature che ballano con bei giovanotti tastando loro il posteriore, o commensali attorno a specie di triclini. "Just the right amount of wrong", solo la dose giusta di errore e trasgressione, è lo slogan.
I maligni hanno gioco facile a paragonare il comportamento delle banche nella crisi internazionale con il gioco d' azzardo: hanno guadagnato scommettendo su crolli azionari o successi di film, hanno lanciato molti prodotti di cui solo pochi garantivano soldi. Come appunto in un casinò. Ma Las Vegas ha conosciuto anche bancarotte: nel 2007 fallì la investment bank Bear Stearns, e trascinò nel crollo la Fontainebleau, che gestiva una delle maggiori case. Carl Icahn la rilevò dai curatori fallimentari per "appena" 150 milioni di dollari. In tanti modi, dopo il faites votre jeu può arrivare il rien ne va plus.
Il secondo esempio è dell'autunno 2009. Un titolo sul Sole 24 ore recita: “Da ingegnere della finanza a mago del poker online”. La crisi della finanza, di un certo modo di fare finanza, è coincisa con il boom del poker. E' possibile, credo, cogliere connessioni tra i due trend. Potremmo dire che non c'è soluzione di continuità tra il trading on line e il giocare a poker. In entrambi i casi, si scommette il denaro sulla capacità di intercettare situazioni emergenti. Una discontinuità sta semmai nel fatto che chi fa trading on line può mettere in gioco denaro proprio, ma anche denaro altrui che gli è stato affidato in gestione. Mentre se gioco a poker, metto in gioco denaro vero o virtuale, ma sempre denaro di mia proprietà.
Non c'è da meravigliarsi che persone espulse per un verso dal mercato del lavoro, rientrino in scena su un mercato parallelo che premia le stesse attitudini e le stesse abilità: gestione del rischio rapidità di decisione, lettura dei segnali deboli, consuetudine con l'intangibile. Ma si può anche allargare il discorso. Si può ragionevolmente dire, senza che l'analogia appaia forzata, che un certo deleterio modo di intendere e di imporre al mondo la finanza che oggi domina il mondo è giocare a poker. Giocare a poker con il denaro altrui. Il denaro affidato alle istituzioni finanziarie, è presto spogliato di informazioni relative alla fonte, è presto spogliato dagli indirizzi che colui che mi ha affidato il suo denaro aveva in mente. Lo spazio aperto alle intenzioni di coloro che forniscono il denaro è ben delimitato. L'asimmetria di potere e di informazioni permette alla finanza di fare ciò che vuole.
L'analogia con il poker, mi pare, mette in luce l'essenza della finanza degenerata che abbiamo sotto gli occhi. Così come il poker, la finanza si fonda sul bluff. To brag, boast, to baffle, mislead. Vantarsi, millantare, confondere, trarre in inganno. A qualsiasi valore costruito lavorando, si sostituisce il valore apparente millantato al tavolo da gioco. Il più abile, il vincitore, è chi è più capace a vendere fumo e ad ingannare. Difficile concepire qualcosa di più riprovevole da un punto di vista etico.
Lì citavo Balzac e la sua Parigi e il suo tempo. In particolar modo, credo, avevo in mente Illusions perdues (1843).
Scrivevo:
La società è una palestra di interessi economici: tutti vi siamo implicati, si vale solo se si riesce ad imporsi. "Il successo è divenuto il principio supremo di un'epoca atea", il sigillo dei tempi nuovi, sia in industria che in economia arte e spirito. Si assiste al "dilagare della finanza". Non è più possibile distinguere un commerciante da un pari di Francia; il nuovo titolo di nobiltà nella della società moderna è l'essere "il più tassato di tutto il circondario". Politica amore e arte sono diretti dal denaro. La produzione in serie distrugge il valore artistico e artigianale del lavoro: "nous avons des produits, nous n'avons plus d'oeuvres". Non conta più "l'energia isolata, ricca di creazioni originali", conta invece "l'energia uniforme, ma livellatrice, che parifica i prodotti, li produce in massa, obbedendo a una idea unitaria".
In Contro il Management cito Zola, L’Argent (1891). Sono passati cinquant'anni, lo scenario si è evoluto, ma gli elementi di fondo del quadro non è cambiato. La pressione della finanza è sempre più evidente. La Borsa -già intesa nel 1808 da Napoleone, quando pose la prima pietra del palazzo che doveva ospitarla, come "le thermomètre de la confiance publique"- è l'ombelico del mondo fondato sulla finanza.
Si completa il disegno già descritto da Balzac, un disegno sociale economico, ma anche di pianificazione urbanistica e territoriale. Le fabbriche stanno in periferia, in provincia. Il centro della metropoli, invece, si identifica con la finanza, ed il suo luogo simbolico: la Borsa. Ecco la Parigi di Napoleone III nel 1867, alla vigilia dell'Exposition Universelle, freneticamente attiva, assordata dal rumore dei cantieri aperti dal prefetto Haussmann, che sventra la città e la rimodella come moderno salotto di boulevard e gallerie commerciali. E al centro, qui, come in quegli stessi anni a Londra e a New York, la Borsa.
La speculazione finanziaria si sostituisce al lavoro. Rappresenta in forma semplificata ed estrema “l'eterno desiderio che spinge a lottare e a vivere”. “Un grande sogno, da un soldo ricavarne cento”. Zola, nel romanzo L'Argent, ci descrive meglio di qualsiasi economista, di qualsiasi storico o sociologo il significato sociale di questo luogo: frastuono spaventoso, continuo gesticolare degli agenti, “danzante mimica dei corpi, quasi pronti a divorarsi reciprocamente”, trionfi, crolli, speranze, duri dati di realtà. Aristide Saccard, protagonista romanzo “è veramente il poeta del milione”. “I suoi figli, le sue donne, insomma tutto ciò che lo circonda, viene per lui dopo il denaro”. “Non era forse, il denaro, e soltanto il denaro, la forza che può spianare una montagna, colmare un braccio di mare, rendere la terra finalmente abitabile per gli uomini, liberati dal giogo del lavoro che abbruttisce, facendoli diventare conduttori di macchine?”.
Come sostengo in altri miei libri, e anche in Contro il management, nessun sociologo, nessuno storico, nessuno studioso di discipline economiche e aziendalistiche sa descrivere il mondo della fianza e dell'impresa come sanno fare i romanzieri. Quindi, anche se non mi viene in mente al momento nessun romanzo contemporaneo comparabile con Le illusioni perdute e Denaro, credo che né Balzac ne Zola siano eccezioni. Quello che è certo è che il materiale romanzesco non manca.
Bastano due esempi. Il primo: una notizia apparsa di recente sulla stampa parla del nuovo investimento della Deutsche Bank. Cito da Repubblica del 17 dicembre 2010: la Deutsche Bank, la più forte, moderna e globale banca d' affari tedesca, ha appena aperto un gigantesco casinò di superlusso, con annesso hotel, a Las Vegas. The Cosmopolitan, si chiama la nuova super-casa da gioco voluta dai signori della finanza di Francoforte.
Hanno investito 4 miliardi di dollari per realizzare l' enorme grattacielo, un nuovo simbolo della metropoli del gioco d' azzardo. Ben 83 tavoli da gioco, 1474 slot machines di ogni genere,e tremila tra cameree suites. Deutsche Bank si mostra come sempre sicura di aver fatto centro: alla fine, tra i tanti giocatori d' azzardo che saranno suoi ospiti, qualcuno vincerà alla roulette, al poker o alle slot machines, ma alla fine i grandi profitti li realizzerà il colosso finanziario. La certezza di non aver sbagliato è tanta che gli spot pubblicitari per l' apertura mostrano signore mature che ballano con bei giovanotti tastando loro il posteriore, o commensali attorno a specie di triclini. "Just the right amount of wrong", solo la dose giusta di errore e trasgressione, è lo slogan.
I maligni hanno gioco facile a paragonare il comportamento delle banche nella crisi internazionale con il gioco d' azzardo: hanno guadagnato scommettendo su crolli azionari o successi di film, hanno lanciato molti prodotti di cui solo pochi garantivano soldi. Come appunto in un casinò. Ma Las Vegas ha conosciuto anche bancarotte: nel 2007 fallì la investment bank Bear Stearns, e trascinò nel crollo la Fontainebleau, che gestiva una delle maggiori case. Carl Icahn la rilevò dai curatori fallimentari per "appena" 150 milioni di dollari. In tanti modi, dopo il faites votre jeu può arrivare il rien ne va plus.
Il secondo esempio è dell'autunno 2009. Un titolo sul Sole 24 ore recita: “Da ingegnere della finanza a mago del poker online”. La crisi della finanza, di un certo modo di fare finanza, è coincisa con il boom del poker. E' possibile, credo, cogliere connessioni tra i due trend. Potremmo dire che non c'è soluzione di continuità tra il trading on line e il giocare a poker. In entrambi i casi, si scommette il denaro sulla capacità di intercettare situazioni emergenti. Una discontinuità sta semmai nel fatto che chi fa trading on line può mettere in gioco denaro proprio, ma anche denaro altrui che gli è stato affidato in gestione. Mentre se gioco a poker, metto in gioco denaro vero o virtuale, ma sempre denaro di mia proprietà.
Non c'è da meravigliarsi che persone espulse per un verso dal mercato del lavoro, rientrino in scena su un mercato parallelo che premia le stesse attitudini e le stesse abilità: gestione del rischio rapidità di decisione, lettura dei segnali deboli, consuetudine con l'intangibile. Ma si può anche allargare il discorso. Si può ragionevolmente dire, senza che l'analogia appaia forzata, che un certo deleterio modo di intendere e di imporre al mondo la finanza che oggi domina il mondo è giocare a poker. Giocare a poker con il denaro altrui. Il denaro affidato alle istituzioni finanziarie, è presto spogliato di informazioni relative alla fonte, è presto spogliato dagli indirizzi che colui che mi ha affidato il suo denaro aveva in mente. Lo spazio aperto alle intenzioni di coloro che forniscono il denaro è ben delimitato. L'asimmetria di potere e di informazioni permette alla finanza di fare ciò che vuole.
L'analogia con il poker, mi pare, mette in luce l'essenza della finanza degenerata che abbiamo sotto gli occhi. Così come il poker, la finanza si fonda sul bluff. To brag, boast, to baffle, mislead. Vantarsi, millantare, confondere, trarre in inganno. A qualsiasi valore costruito lavorando, si sostituisce il valore apparente millantato al tavolo da gioco. Il più abile, il vincitore, è chi è più capace a vendere fumo e ad ingannare. Difficile concepire qualcosa di più riprovevole da un punto di vista etico.
mercoledì 15 dicembre 2010
Quello che i manager non dicono
Un manager mi scrive: “Francesco, Contro il Management è una lettura interessante ed appassionante. Ti ringrazio per gli spunti che dai e per la profondità di pensiero che porti”.
Altri manager che conosco altrettanto bene, e che ugualmente stimo, accettano di partecipare a pubblici incontri sui temi che tratto nel libro: l’incombenza della finanza, la caduta dei valori, la rinuncia a ‘dirigere’, la prevalenza degli interessi personali, il sostanziale disinteresse per il lavoro, per la produzione. Capita che si scambi qualche riflessione prima o dopo le parole dette in pubblico. In questi momenti, tutti parlano del pessimo clima circostante, del malessere, dell’ingiustizia diffusa, di tutto ciò che si è costretti a vedere, a subire.
Ma poi, in pubblico, anche quando il pubblico è una stretta platea di persone come noi, scatta l’autocensura, e vedo che tutto sfuma nell’eufemismo, nell’attenuazione, nella cautela. E allora sento dire che sì, forse i casi di cui parlo accadono in qualche situazione estrema, ma non sono certo diffusi, e comunque non certo nell’azienda dove io lavoro. Sento dire che forse questo accadeva anni fa, ma non ora. Sento dire che nelle medie e piccole imprese un certo tipo di manager che dipingo non c’è proprio. Sento dire che semmai questa immagine del manager fosse vera, riguarderebbe pochissimi Chief Executive di grandi aziende quotate in borsa. Sento dire che certi eccessi, che forse ci sono stati, non possono più presentarsi, perché la Rete obbliga alla trasparenza.
Veder usare Wikileaks come vincolo tale da indurre i manager a comportamenti meno lontani dall’etica, dà la misura del paradosso. I manager, come i politici, combattono la trasparenza informativa come la peste. Salvo poi appellarsi alla trasparenza informativa quando questa serve a negare l’evidenza.
Capisco questi amici. Non possono sbilanciarsi in pubblico. O almeno credono di non poterlo fare. A tratti, ascoltandoli, mi sorgono dubbi. Ho esagerato? Sono stato miope o fazioso? Non credo. Penso di aver scritto a nome loro, dicendo niente di più di quello che questi stessi amici manager in privato dicono.
A consolazione degli amici manager, posso dire dei professori. Un noto accademico, docente di strategia e direttore di master, è intervenuto a una tavola rotonda cui partecipavo anch’io. In pubblico non si è discostato da una difesa d’ufficio del consolidato modello formativo dei master in Business Administration. Master che sono il luogo dove si riproduce il vano sapere manageriale.Difesa che mi è parsa stanca e poco convinta. E’ naturalmente rimasta senza risposta la domanda chiave: come può andar bene un ‘modello unico’ di management. Come può andar bene in genere, di fronte alle differenze culturali; e come può andar bene nello specifico, di fronte ai bisogni del sistema socio-economico dell’Italia di oggi, fatto soprattutto di medie e piccole imprese.
Ma non è questo che mi ha inquietato. Mi ha inquietato quello che ho sentito dire al professore in privato, lontano dal tavolo dei relatori. Lui stesso, che è professore di strategia, non sa darsi risposte. Non sa in che direzione guardare. Non sa che strada prendere, e che strada indicare a chi, confidente nel suo ruolo, gli chiede lumi.
Capisco che il momento è difficile. Ma se siamo classe dirigente, qualche responsabilità dobbiamo pur prendercela. Cominciare guardandoci in faccia, e riconoscendo quello che non va, dicendolo in pubblico e scrivendolo, mi pare, in mancanza di meglio, un buon punto di partenza.
Altri manager che conosco altrettanto bene, e che ugualmente stimo, accettano di partecipare a pubblici incontri sui temi che tratto nel libro: l’incombenza della finanza, la caduta dei valori, la rinuncia a ‘dirigere’, la prevalenza degli interessi personali, il sostanziale disinteresse per il lavoro, per la produzione. Capita che si scambi qualche riflessione prima o dopo le parole dette in pubblico. In questi momenti, tutti parlano del pessimo clima circostante, del malessere, dell’ingiustizia diffusa, di tutto ciò che si è costretti a vedere, a subire.
Ma poi, in pubblico, anche quando il pubblico è una stretta platea di persone come noi, scatta l’autocensura, e vedo che tutto sfuma nell’eufemismo, nell’attenuazione, nella cautela. E allora sento dire che sì, forse i casi di cui parlo accadono in qualche situazione estrema, ma non sono certo diffusi, e comunque non certo nell’azienda dove io lavoro. Sento dire che forse questo accadeva anni fa, ma non ora. Sento dire che nelle medie e piccole imprese un certo tipo di manager che dipingo non c’è proprio. Sento dire che semmai questa immagine del manager fosse vera, riguarderebbe pochissimi Chief Executive di grandi aziende quotate in borsa. Sento dire che certi eccessi, che forse ci sono stati, non possono più presentarsi, perché la Rete obbliga alla trasparenza.
Veder usare Wikileaks come vincolo tale da indurre i manager a comportamenti meno lontani dall’etica, dà la misura del paradosso. I manager, come i politici, combattono la trasparenza informativa come la peste. Salvo poi appellarsi alla trasparenza informativa quando questa serve a negare l’evidenza.
Capisco questi amici. Non possono sbilanciarsi in pubblico. O almeno credono di non poterlo fare. A tratti, ascoltandoli, mi sorgono dubbi. Ho esagerato? Sono stato miope o fazioso? Non credo. Penso di aver scritto a nome loro, dicendo niente di più di quello che questi stessi amici manager in privato dicono.
A consolazione degli amici manager, posso dire dei professori. Un noto accademico, docente di strategia e direttore di master, è intervenuto a una tavola rotonda cui partecipavo anch’io. In pubblico non si è discostato da una difesa d’ufficio del consolidato modello formativo dei master in Business Administration. Master che sono il luogo dove si riproduce il vano sapere manageriale.Difesa che mi è parsa stanca e poco convinta. E’ naturalmente rimasta senza risposta la domanda chiave: come può andar bene un ‘modello unico’ di management. Come può andar bene in genere, di fronte alle differenze culturali; e come può andar bene nello specifico, di fronte ai bisogni del sistema socio-economico dell’Italia di oggi, fatto soprattutto di medie e piccole imprese.
Ma non è questo che mi ha inquietato. Mi ha inquietato quello che ho sentito dire al professore in privato, lontano dal tavolo dei relatori. Lui stesso, che è professore di strategia, non sa darsi risposte. Non sa in che direzione guardare. Non sa che strada prendere, e che strada indicare a chi, confidente nel suo ruolo, gli chiede lumi.
Capisco che il momento è difficile. Ma se siamo classe dirigente, qualche responsabilità dobbiamo pur prendercela. Cominciare guardandoci in faccia, e riconoscendo quello che non va, dicendolo in pubblico e scrivendolo, mi pare, in mancanza di meglio, un buon punto di partenza.
Etichette:
Business Ethics,
Pars Construens
domenica 26 settembre 2010
Adriano Olivetti, Sergio Marchionne, Kitarō Nishida: perché le automobili Fiat sono brutte
Il 22 settembre 2010 ho partecipato, a Parma, presso l'Unione Parmense degli Industriali, Palazzo Soragna, al convegno Il valore dell'etica e dell'estetica nell'agire d'impresa. Si tratta della seconda tappa del percorso Adriano Olivetti Uno organizzato, con l'associazione Vita Eudaimonica, da Alberto Peretti.
A seguito del più teorico intervento del filosofo Aldo Natoli -il problema dei filosofi che parlano di lavoro e di organizzazione e di azienda, è che non hanno mai vito da vicino una fabbrica, un'azienda-, ho parlato sul tema: Estetica e Globalizzazione. Luogh, non luoghi e scelte del management.
Leggo in un articolo di Antonella Del Gesso apparso sulla Gazzetta di Parma:
«Oggi c'è una totale lacerazione tra impresa e territorio», commenta filosofo Salvatore Natoli. «E' questo il principio su cui si basa la finanza: immaginare di poter produrre a prescindere dall’esistenza di un luogo fisico. E i risultati di questa politica si sono visti», aggiunge il consulente e formatore Francesco Varanini.
Non preparo mai come tesi finiti gli interventi a convegni, o le conferenze, perché preferisco scoprire il discorso che emerge nella situazione, in quel momento, in relazione con gli astanti e con ciò che dicono gli altri relatori.
In questo caso però mi è capitato di scrivere un testo compiuto sul tema che mi era stato assegnato. Mentre scrivevo, mi è apparso come titolo più adeguato Le automobili Fiat sono così brutte perché Marchonne guadagna troppo.
La ragione del titolo sta nel paragrafo che trascrivo qui sotto.
Anche i competitori globali della Fiat sono costretti ad operare su un mercato dominato dalla finanza. Ma evidentemente a loro la qualità e il valore dell'automobile, il bello e il buono interessano di più. Se non fosse così, non sarebbe così evidente la differenza tra un'automobile tedesca e un'automobile italiana.
Possiamo, a ragion veduta, dire che, da un punto di vista etico, Marchionne guadagna troppo, visto le brutte automobili che la Fiat produce. Ma possiamo, a maggior motivo, dire che la Fiat fa brutte automobili perché Marchionne guadagna troppo.
Quando c'era Valletta le automobili della Fiat erano più belle, più ricche di valore percepito da lavoratori e da clienti. Valletta guadagnava venti volte più di un operaio della Fiat. Non era troppo lontano. Riusciva a capire, gli interessava capire, come pensa e come vive un operaio. Dedicava tempo all'organizzazione del lavoro, della produzione. La sua retribuzione dipendeva dal consenso dei sindacati, era dunque consapevolmente pagato anche dagli operai. E al contempo era pagato da chi comprava automobili Fiat. Considerava importante l'opinione dei clienti, degli automobilisti.
Marchionne guadagna quattrocento volte quanto guadagna un operaio. E' troppo lontano da operai e clienti. Non ha tempo per loro. Non gli interessa capire come pensa e come vive un operaio, né come coltivare e portare a valore le conoscenze dell'operaio. Dedica tempo innanzitutto agli investitori finanziari. Il suo scopo non è, in realtà, vendere o produrre automobili. Il suo scopo è rispondere alle aspettative del mercato finanziario. E' pagato non da operai e da clienti, ma da rentier -famiglia Agnelli, investitori di borsa, banche, operatori del mercato finanziario: banche, società di rating- in fondo come lui disinteressati alle automobili.
Agli investitori finanziari, ai percettori di reddito legato al valore di borsa -tra cui sta anche la famiglia Agnelli, e sta lo stesso Marchionne- importa ben poco dove sono prodotte le automobili, importa ben poco come sono prodotte le automobili. Importa ben poco produrre automobili che siano giudicate buone dai clienti. Importa solo che, con artifici contabilità o di comunicazione, il titolo faccia bella figura in borsa.
Il fatto che la Fiat di Marchionne produca automobili non è che un accidente, una infausta coincidenza. Si potrebbe anzi dire che Marchionne ha motivo di disprezzare per le automobili. Ha motivo di essere indispettito perché il comparto produttivo automotive è meno redditizio dal punto di vista finanziario di altri comparti, come elettronica, o energia.
Ho pubblicato questo testo nella sua versione completa qui. Partendo da Adriano Olivetti e dal suo ritener importante il luogo di produzione, si arriva, dal mio punto di vista al concetto di basho del filosofo giapponese Kitarō Nishida.
Ci appare evidente che Nishida ci fa apparire grossolano e ipocrita l'ideologia marchionnesca.
Basho: dove, ubicazione, posto, topos, terra, focolare, base materiale e allo stesso tempo spirituale. Non radici alle quali siamo vincolati, ma luogo che abitiamo.
Non ci può essere produzione, non ci può essere etica ed estetica, non c'è bello, né bene, né buono se non c'è basho.
L'esperienza che in ogni istante stiamo vivendo si situa in un qui. Solo se c'è basho c'è impresa e organizzazione che le persone possono intendere come dotata di senso.
A seguito del più teorico intervento del filosofo Aldo Natoli -il problema dei filosofi che parlano di lavoro e di organizzazione e di azienda, è che non hanno mai vito da vicino una fabbrica, un'azienda-, ho parlato sul tema: Estetica e Globalizzazione. Luogh, non luoghi e scelte del management.
Leggo in un articolo di Antonella Del Gesso apparso sulla Gazzetta di Parma:
«Oggi c'è una totale lacerazione tra impresa e territorio», commenta filosofo Salvatore Natoli. «E' questo il principio su cui si basa la finanza: immaginare di poter produrre a prescindere dall’esistenza di un luogo fisico. E i risultati di questa politica si sono visti», aggiunge il consulente e formatore Francesco Varanini.
Non preparo mai come tesi finiti gli interventi a convegni, o le conferenze, perché preferisco scoprire il discorso che emerge nella situazione, in quel momento, in relazione con gli astanti e con ciò che dicono gli altri relatori.
In questo caso però mi è capitato di scrivere un testo compiuto sul tema che mi era stato assegnato. Mentre scrivevo, mi è apparso come titolo più adeguato Le automobili Fiat sono così brutte perché Marchonne guadagna troppo.
La ragione del titolo sta nel paragrafo che trascrivo qui sotto.
Anche i competitori globali della Fiat sono costretti ad operare su un mercato dominato dalla finanza. Ma evidentemente a loro la qualità e il valore dell'automobile, il bello e il buono interessano di più. Se non fosse così, non sarebbe così evidente la differenza tra un'automobile tedesca e un'automobile italiana.
Possiamo, a ragion veduta, dire che, da un punto di vista etico, Marchionne guadagna troppo, visto le brutte automobili che la Fiat produce. Ma possiamo, a maggior motivo, dire che la Fiat fa brutte automobili perché Marchionne guadagna troppo.
Quando c'era Valletta le automobili della Fiat erano più belle, più ricche di valore percepito da lavoratori e da clienti. Valletta guadagnava venti volte più di un operaio della Fiat. Non era troppo lontano. Riusciva a capire, gli interessava capire, come pensa e come vive un operaio. Dedicava tempo all'organizzazione del lavoro, della produzione. La sua retribuzione dipendeva dal consenso dei sindacati, era dunque consapevolmente pagato anche dagli operai. E al contempo era pagato da chi comprava automobili Fiat. Considerava importante l'opinione dei clienti, degli automobilisti.
Marchionne guadagna quattrocento volte quanto guadagna un operaio. E' troppo lontano da operai e clienti. Non ha tempo per loro. Non gli interessa capire come pensa e come vive un operaio, né come coltivare e portare a valore le conoscenze dell'operaio. Dedica tempo innanzitutto agli investitori finanziari. Il suo scopo non è, in realtà, vendere o produrre automobili. Il suo scopo è rispondere alle aspettative del mercato finanziario. E' pagato non da operai e da clienti, ma da rentier -famiglia Agnelli, investitori di borsa, banche, operatori del mercato finanziario: banche, società di rating- in fondo come lui disinteressati alle automobili.
Agli investitori finanziari, ai percettori di reddito legato al valore di borsa -tra cui sta anche la famiglia Agnelli, e sta lo stesso Marchionne- importa ben poco dove sono prodotte le automobili, importa ben poco come sono prodotte le automobili. Importa ben poco produrre automobili che siano giudicate buone dai clienti. Importa solo che, con artifici contabilità o di comunicazione, il titolo faccia bella figura in borsa.
Il fatto che la Fiat di Marchionne produca automobili non è che un accidente, una infausta coincidenza. Si potrebbe anzi dire che Marchionne ha motivo di disprezzare per le automobili. Ha motivo di essere indispettito perché il comparto produttivo automotive è meno redditizio dal punto di vista finanziario di altri comparti, come elettronica, o energia.
Ho pubblicato questo testo nella sua versione completa qui. Partendo da Adriano Olivetti e dal suo ritener importante il luogo di produzione, si arriva, dal mio punto di vista al concetto di basho del filosofo giapponese Kitarō Nishida.
Ci appare evidente che Nishida ci fa apparire grossolano e ipocrita l'ideologia marchionnesca.
Basho: dove, ubicazione, posto, topos, terra, focolare, base materiale e allo stesso tempo spirituale. Non radici alle quali siamo vincolati, ma luogo che abitiamo.
Non ci può essere produzione, non ci può essere etica ed estetica, non c'è bello, né bene, né buono se non c'è basho.
L'esperienza che in ogni istante stiamo vivendo si situa in un qui. Solo se c'è basho c'è impresa e organizzazione che le persone possono intendere come dotata di senso.
Etichette:
Business Ethics,
Corporate Social Responsibility,
Maestri
sabato 21 agosto 2010
Pars Construens: Chiasmo Biblico
Credo sia giusto, a partire dall’indignazione e dalla consapevolezza dell’ingiustizia, criticare il management. Questo ho fatto nella prima parte del libro. Ma ho cercato anche, in una seconda parte, di descrivere un modo di dirigere l’impresa fondato su sul rispetto di se stessi e la considerazione degli altri.
Come dico nel libro, si possono trovare tracce di questo atteggiamento -orientato alla guida, al governo e alla cura- in culture lontane, come il buddhismo. Ma anche in fonti più vicine a noi, alla nostra formazione e alla nostra cultura, come è il testo biblico.
Questo incrocio di quattro assi, quattro chiavi di lettura del mondo, quattro atteggiamenti -che credo compresenti, almeno in qualche misura, in ognuno di noi- l’ho in mente da tanto tempo. Mi ha fatto piacere riprenderlo qui, in questo libro tramite il quale faccio i conti con una non trascurabile porzione della mia vita.
Portare la propria croce
Il latino labor esprime l'idea di attività dura e penosa. Idea probabilmente ricavata dal verbo labare: 'vacillare sotto un peso'.
Anche il francese, lo spagnolo e portoghese (travail, trabajo, trabalho) ci parlano di sofferenza. Tripalium: strumento di tortura -tre pali, croce- al quale il reo è costretto. Così è qualsiasi lavoro.
Ogni persona al lavoro è chiamata a 'farsi carico'. Vive il suo calvario. Sopporta pesi, patisce ingiustizie. Sulle sue spalle grava il peso di una croce, quella stessa croce alla quale sarà inchiodato se le cose non andranno per il verso giusto.
Allo stesso tempo, la croce che ognuno porta, è il mezzo attraverso il quale gli altri saranno salvati.
Il comune obiettivo impone a ognuno di considerare propria la croce dell’altro. Così il ‘portare la propria croce’ si manifesta come servizio.
Il latino servum, ben prima dall'indicare lo 'schiavo', parlava di 'guardiano di greggi'. La radice indoeuropea swer- esprime un insieme di concetti di grande respiro: 'vedere', 'guardare', 'conservare'. Fornire garanzia, salvaguardia, difesa. Da swer-, il sanscrito varutá, 'protettore'; il greco horán ('vedere'); così come il latino observare: ob, ‘verso’ servare, ‘custodire’, con la duplice accezione di 'fare attenzione', 'adempiere', e di 'non togliere mai gli occhi di dosso'.
Il servizio è connesso alla visione, alla saggezza, alla conoscenza.
Come si legge nel capitolo 42 di Isaia (Isaia, 42, 2-4), a proposito del Servo di Javhé, possiamo pensare, al posto del manager, ad una persona che
Non griderà né alzerà il tono,
non farà udire in piazza la sua voce,
non spezzerà una canna incrinata,
non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta.
Proclamerà il diritto con fermezza;
non verrà meno e non si abbatterà.
Essere come Dio
Chi guida, governa, cura l'azienda è sostituto del Dio assente. Non può garantire che le aspettative dei diversi portatori di interessi siano soddisfatte. Ma può essere garante di un terreno comune, di uno spazio per l'ambizione.
Lontana dall'arroganza del manager, l’ambizione è desiderio vivo. Chiunque ben intende la natura dell'impresa, chi vive in azienda, desidera andare oltre i limiti di ciò che si vede, si confronta con l’ignoto, parla di ciò che non c’è ancora. E' portatore di speranza.
Nel caos della vita quotidiana dell'azienda, dove domina, nonostante tutti i piani ed i programmi, il massimo disordine, proprio lì è possibile cogliere le radici del mondo emergente. Le parole di chi guida, governa, cura l'azienda, così come le sue azioni, illuminano la scena, guardano senza timore il caos. Sciolgono il garbuglio e indirizzano il lavoro verso lo scopo. (Isaia 65, 17-18)
Ecco infatti io creo nuovi cieli e nuova terra
non si ricorderà più il passato,
non verrà più in mente,
poiché si godrà e si gioirà sempre
di quello che sto per creare.
Costruire pietra su pietra
L'azienda è lenta e attenta costruzione. Costruire è lavorare con attenzione, consapevolezza dei dettagli.
Costruire è porre attenzione alla struttura: alle correlazioni, alle interdipendenze, alle connessioni.
Costruire pietra su pietra significa ricordare che l'azienda si costruisce innanzitutto mettendo le basi, partendo dalle fondamenta. (Isaia 28,16)
Ecco io pongo una pietra in Sion,
una pietra scelta,
angolare, preziosa, saldamente fondata:
chi crede non vacillerà.
Eppure chi guida, governa, cura l'azienda non può cercare una astratta perfezione. Dobbiamo costruire con le pietre che troviamo. Così, recuperando colonne di templi romani si costruivano le cattedrali romaniche. La migliore delle pietre possibili è quella che riesco ad avere a disposizione mentre lavoro. Su queste pietre ‘non ottime’ si fonda la costruzione che mi è dato di realizzare. (Salmo 118, 22)
La pietra scartata dai costruttori
è divenuta testata d'angolo
Gettare il pane alle onde
Getta il pane alle onde, alla lunga lo ritroverai, dice Qohelet (Ecclesiaste 11, 1). La 'cultura orientale' alla quale mi ero avvicinato da lontano, in punta di piedi, guardando alla lezione buddista, è portata da Qohelet nel cuore della nostra 'cultura occidentale'.
L'azienda si guida, si governa, si cura dando prova, giorno dopo giorno, di confidenza e fiducia, di rispetto per se stessi e di considerazione per gli altri, di serenità d’animo. Lo scopo si avvicina mettendo da parte l’illusione e l’attaccamento ad ogni fonte di rassicurazione. (Ecclesiaste, 3, 1; Ecclesiaste, 4-7)
Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo.
Un tempo per piangere e un tempo per ridere,
un tempo per gemere e un tempo per ballare.
Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli,
Un tempo per cercare e un tempo per perdere,
un tempo per serbare e un tempo per buttar via.
Un tempo per stracciare e un tempo per cucire,
un tempo per tacere e un tempo per parlare.
Non c’è nessuna ragione, nessun modello che può dirci quale è il ‘momento propizio’ per agire, per fare una o un’altra cosa. Né la ragione ci aiuta a leggere i segnali deboli, a cogliere il momento in cui si avvicina la tempesta.
Qohelet ci esorta a ‘lasciar vivere’ l'azienda, minimizzando i requisiti e limitando il controllo. Laa saggezza è più importante della ragione. La saggezza è moderazione, equilibrio, ed è conoscenza delle cose acquisita con l’esperienza.
Gettare il pane alle onde: accettare l'azienda che ‘si fa’, sorvegliare come si guarda il gregge, o il grano che cresce.
Come dico nel libro, si possono trovare tracce di questo atteggiamento -orientato alla guida, al governo e alla cura- in culture lontane, come il buddhismo. Ma anche in fonti più vicine a noi, alla nostra formazione e alla nostra cultura, come è il testo biblico.
Questo incrocio di quattro assi, quattro chiavi di lettura del mondo, quattro atteggiamenti -che credo compresenti, almeno in qualche misura, in ognuno di noi- l’ho in mente da tanto tempo. Mi ha fatto piacere riprenderlo qui, in questo libro tramite il quale faccio i conti con una non trascurabile porzione della mia vita.
Portare la propria croce
Il latino labor esprime l'idea di attività dura e penosa. Idea probabilmente ricavata dal verbo labare: 'vacillare sotto un peso'.
Anche il francese, lo spagnolo e portoghese (travail, trabajo, trabalho) ci parlano di sofferenza. Tripalium: strumento di tortura -tre pali, croce- al quale il reo è costretto. Così è qualsiasi lavoro.
Ogni persona al lavoro è chiamata a 'farsi carico'. Vive il suo calvario. Sopporta pesi, patisce ingiustizie. Sulle sue spalle grava il peso di una croce, quella stessa croce alla quale sarà inchiodato se le cose non andranno per il verso giusto.
Allo stesso tempo, la croce che ognuno porta, è il mezzo attraverso il quale gli altri saranno salvati.
Il comune obiettivo impone a ognuno di considerare propria la croce dell’altro. Così il ‘portare la propria croce’ si manifesta come servizio.
Il latino servum, ben prima dall'indicare lo 'schiavo', parlava di 'guardiano di greggi'. La radice indoeuropea swer- esprime un insieme di concetti di grande respiro: 'vedere', 'guardare', 'conservare'. Fornire garanzia, salvaguardia, difesa. Da swer-, il sanscrito varutá, 'protettore'; il greco horán ('vedere'); così come il latino observare: ob, ‘verso’ servare, ‘custodire’, con la duplice accezione di 'fare attenzione', 'adempiere', e di 'non togliere mai gli occhi di dosso'.
Il servizio è connesso alla visione, alla saggezza, alla conoscenza.
Come si legge nel capitolo 42 di Isaia (Isaia, 42, 2-4), a proposito del Servo di Javhé, possiamo pensare, al posto del manager, ad una persona che
Non griderà né alzerà il tono,
non farà udire in piazza la sua voce,
non spezzerà una canna incrinata,
non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta.
Proclamerà il diritto con fermezza;
non verrà meno e non si abbatterà.
Essere come Dio
Chi guida, governa, cura l'azienda è sostituto del Dio assente. Non può garantire che le aspettative dei diversi portatori di interessi siano soddisfatte. Ma può essere garante di un terreno comune, di uno spazio per l'ambizione.
Lontana dall'arroganza del manager, l’ambizione è desiderio vivo. Chiunque ben intende la natura dell'impresa, chi vive in azienda, desidera andare oltre i limiti di ciò che si vede, si confronta con l’ignoto, parla di ciò che non c’è ancora. E' portatore di speranza.
Nel caos della vita quotidiana dell'azienda, dove domina, nonostante tutti i piani ed i programmi, il massimo disordine, proprio lì è possibile cogliere le radici del mondo emergente. Le parole di chi guida, governa, cura l'azienda, così come le sue azioni, illuminano la scena, guardano senza timore il caos. Sciolgono il garbuglio e indirizzano il lavoro verso lo scopo. (Isaia 65, 17-18)
Ecco infatti io creo nuovi cieli e nuova terra
non si ricorderà più il passato,
non verrà più in mente,
poiché si godrà e si gioirà sempre
di quello che sto per creare.
Costruire pietra su pietra
L'azienda è lenta e attenta costruzione. Costruire è lavorare con attenzione, consapevolezza dei dettagli.
Costruire è porre attenzione alla struttura: alle correlazioni, alle interdipendenze, alle connessioni.
Costruire pietra su pietra significa ricordare che l'azienda si costruisce innanzitutto mettendo le basi, partendo dalle fondamenta. (Isaia 28,16)
Ecco io pongo una pietra in Sion,
una pietra scelta,
angolare, preziosa, saldamente fondata:
chi crede non vacillerà.
Eppure chi guida, governa, cura l'azienda non può cercare una astratta perfezione. Dobbiamo costruire con le pietre che troviamo. Così, recuperando colonne di templi romani si costruivano le cattedrali romaniche. La migliore delle pietre possibili è quella che riesco ad avere a disposizione mentre lavoro. Su queste pietre ‘non ottime’ si fonda la costruzione che mi è dato di realizzare. (Salmo 118, 22)
La pietra scartata dai costruttori
è divenuta testata d'angolo
Gettare il pane alle onde
Getta il pane alle onde, alla lunga lo ritroverai, dice Qohelet (Ecclesiaste 11, 1). La 'cultura orientale' alla quale mi ero avvicinato da lontano, in punta di piedi, guardando alla lezione buddista, è portata da Qohelet nel cuore della nostra 'cultura occidentale'.
L'azienda si guida, si governa, si cura dando prova, giorno dopo giorno, di confidenza e fiducia, di rispetto per se stessi e di considerazione per gli altri, di serenità d’animo. Lo scopo si avvicina mettendo da parte l’illusione e l’attaccamento ad ogni fonte di rassicurazione. (Ecclesiaste, 3, 1; Ecclesiaste, 4-7)
Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo.
Un tempo per piangere e un tempo per ridere,
un tempo per gemere e un tempo per ballare.
Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli,
Un tempo per cercare e un tempo per perdere,
un tempo per serbare e un tempo per buttar via.
Un tempo per stracciare e un tempo per cucire,
un tempo per tacere e un tempo per parlare.
Non c’è nessuna ragione, nessun modello che può dirci quale è il ‘momento propizio’ per agire, per fare una o un’altra cosa. Né la ragione ci aiuta a leggere i segnali deboli, a cogliere il momento in cui si avvicina la tempesta.
Qohelet ci esorta a ‘lasciar vivere’ l'azienda, minimizzando i requisiti e limitando il controllo. Laa saggezza è più importante della ragione. La saggezza è moderazione, equilibrio, ed è conoscenza delle cose acquisita con l’esperienza.
Gettare il pane alle onde: accettare l'azienda che ‘si fa’, sorvegliare come si guarda il gregge, o il grano che cresce.
domenica 18 luglio 2010
Etica e strumenti
Lo scritto che segue era apparso (come commento a: Mario Viviani, “Il bilancio sociale negli enti locali”), su Sviluppo & Organizzazione, n. 204, luglio/agosto 2004, p. 94.
Avevo quasi dimenticato di avere scritto queste pagine. Che avrebbero potuto anche entrare nel testo di Contro il management. E che comunque ne costituiscono una significativa anticipazione – in particolare per alcuni dei temi trattati: la compresenza dei diversi stakeholder, l'etica degli affari (o business ethics che dir si voglia), la Corporate Social Responsibility, la centralità e i limiti delle rilevazioni contabili e bilancistiche, le metriche e gli asset intangibili.
Sono passati sei anni. Mi ritrovo in quello che ho scritto, salvo su un punto. In conclusione critico Bilanci Sociali, Carte dei valori, e in genere tutte le nuove metriche, oggi tanto di moda, tese a descrivere la qualità etica dell'impresa. Affermo quindi che è meglio restare sul concreto e lavorare intanto per rendere più trasparenti e completi i tradizionali 'bilanci d'esercizio' fondati sulla rilevazione contabile.
Confermo la critica di nuovi strumento e nuove metriche. Ma sono diventato più scettico e guardingo al riguardo del bilancio d'esercizio. Come scrivo in Contro il management: il bilancio, lungi dall'incamminarsi verso l'esssere uno strumento descrittivo rispettoso della complessa realtà dell'impresa, è lo strumento, direi quasi il grimaldello, attraverso il quale un solo stakeholder -la finanza nellesue diverse manifestazioni: banca, investitori istituzionali, borsa- subordina l'impresa al suo comando. Insomma: il bilancio potrebbe essere sì equanime, ma in realtà è redatto per dire dell'azienda solo ciò che la finanza vuol sentirsi dire.
Immaginate un edificio abbellito da accattivanti insegne sulla facciata e da bandiere sventolanti sul tetto. Immaginate che questo lussuoso apparato comunicativo sia ostentato come significativa miglioria. Eppure chi vive nell’edificio sa –o dovrebbe sapere– che le fondamenta sono poco solide, e che i sotterranei sono infestati da topi, e sono anche luogo di turpi commerci.
Comunicazione, sovrastruttura, operazione di immagine meramente descrittiva. Questo è, non di rado, il ‘bilancio sociale’, e nel complesso tutta l’impalcatura degli strumenti della Corporate Social Responsibility, CSR (o Responsabilità sociale d’impresa, RSI).
Perché se ne parla tanto, e vi si investono risorse, distogliendole dalla gestione e da azioni orientate al cambiamento, al miglioramento, allo sviluppo? Tutto nasce dal bisogno, diremmo addirittura dalla fame di etica.
La morale non è, in origine, necessaria. E’ del tutto fondato lo scetticismo di chi si domanda ‘perché devo essere morale se l’immoralità consente ad altri di ottenere a buon mercato successo e felicità?’. Trasimaco nella Repubblica di Platone sostiene che l’ingiustizia è più utile della giustizia per chi ha la forza di imporsi agli altri, e che perciò non ha nessun obbligo di seguire le norme che gli impediscono di fare quello che vuole.
Ma la ‘morale’ viene di attualità quando diventa diffusa la percezione del superamento di un limite. Quando si percepisce come eccessiva la sperequazione, la disuguaglianza. Quando è vessata e violata la nostra personale dignità morale, o quella del gruppo cui apparteniamo, o quella di altri a cui riconosciamo la nostra stessa dignità. Quando l’uso della libertà da parte di pochi è uno schiaffo troppo sonoro sul volto di molti. Quando il divario nella distribuzione della ricchezza sfugge al controllo. Quando l’equilibrio dei diritti e delle opportunità appare violato. Quando l’uso delle risorse naturali e lo sfruttamento dell’ambiente rischiano di mettere in discussione il nostro futuro.
Insomma, quando la morale stabilita in una comunità appare, in maniera offensiva, finalizzata solo agli interessi di chi nella comunità stessa detiene il potere, allora emerge il bisogno di un nuovo punto di incontro tra le diverse personali, utilitaristiche, ‘morali’. Allora si manifesta il bisogno di una ‘scienza della morale’, di un’etica.
E’ abbastanza evidente che ci troviamo oggi proprio in questa situazione. Di qui l’attenzione alla ‘sostenibilità’, alla ‘Corporate Governance’, di qui l’accanito dibattito attorno al concetto di stakeholder. Di qui la gran attenzione dedicata alla Corporate Social Responsibility.
Di fronte a tutto questo ciò che desta meraviglia, e che un po’ preoccupa, non è tanto la sostanza –la carenza di etica è un dato di realtà, il bisogno di ‘fare qualcosa’ è perfettamente fondato–. Ciò che meraviglia e preoccupa è l’enfasi del nuovo. C’è tutto il motivo per interrogarsi di nuovo, per rileggere Platone e Aritotele e i Padri della Chiesa e Hobbes e Bentham, Kant, Hobbes, Kant, Rousseau, Fichte, Nietzche, Jaspers, Bonhoeffer e Rawls, e anche magari qualche pagina di Drucker. Si potrebbe riprendere in mano la riflessione sulle regole della convivenza, sul controllo e sul contratto sociale, ed anche sulla teoria pura del diritto e sulle diverse genesi dei patti costituzionali.
Ma invece, salvo qualche dotta citazione, si tende piuttosto a prendere come fondamento qualche recente generico ‘documento ufficiale’, come il Green Paper sulla CSR della Commissione Europea (luglio 2001). E si pretende di trovare le risposte in qualche standard: si pensi in Italia al Progetto Q-RES. Come se l’insoddisfazione morale di fronte al funzionamento delle organizzazioni, e quindi il bisogno di etica, potessero essere risolti sul piano della certificazione. Come se l’etica potesse essere imposta, o garantita, attraverso una norma ISO 9000, 9001 o 9004 che sia.
Di fronte a questo approccio, ben venga la cautela espressa da Mario Viviani. Ma forse c’è da dire qualcosa a voce più alta.
Il problema non sta negli strumenti. E anzi nuovi strumenti rischiano di portare confusione e di favorire soluzioni illusorie. Buone per la ‘società dello spettacolo’, ma lontane alla capacità di incidere sui reali meccanismi del potere e sul reale funzionamento delle organizzazioni. Comunque la si giri il ‘bilancio sociale’ resta uno strumento di secondo livello, una riorganizzazione di informazioni costruita innanzitutto in funzione della facilità di lettura e dell’efficacia comunicativa. E’, al limite, una forma di advertising non tradizionale, vale quanto una sponsorizzazione sportiva o una televendita, o una donazione. Visto che è anche una impalcatura costosa, esistono alternative? Garantisce rispetto allo scopo primario, mettere in luce l’atteggiamento etico dell’organizzazione? Non offre magari dei pericolosi alibi?
Il problema non sta negli strumenti, perché forse gli strumenti esistono già. Il ‘bilancio sociale’ si propone come documento di sintesi, documento che riepiloga i dati più significativi emersi dalla gestione, e che permette di misurare lo scostamento tra l’effettiva gestione e la ‘buona gestione’. Si cerca di affermare il ‘bilancio sociale’ come strumento adatto per ogni persona giuridica, aziende a scopo di lucro, organizzazioni non profit, enti pubblici, lo stesso Stato. Pensate ora a quello strumento di rilevazione che è il bilancio di esercizio. Uno strumento criticabile fin che si vuole. Ma in grado di offrire una sintesi, di riepilogare i dati più significativi emersi dalla gestione, utile per misurare lo scostamento tra l’effettiva gestione e la ‘buona gestione’.E in uso da cinquecento anni, adottato in tutto il mondo, regolato da norme, in grado di permettere confronti.
Perché allora, invece di inventare un nuovo strumento, perché –se si cerca uno strumento in grado di valutare l’etica di una organizzazione– non lavorare a migliorare il ‘bilancio di esercizio’? Se si deve lavorare ad imporre nuovi standard, ben più importante della definizione degli standard di secondo livello tipici del ‘bilancio sociale’ è l’individuazione di parametri attraverso i quali portare alla luce, e a valore, gli asset intantagibili. I brand, gli investimenti in ricerca e sviluppo, le conoscenze detenute da dipendenti e collaboratori, la fidelizzazione dei clienti.
Del resto, si sa che nel bilancio di esercizio fondamentale è la funzione informativa nei confronti delle parti interessante al buon andamento dell'azienda: i dipendenti, i fornitori, i clienti, i finanziatori, il pubblico in generale. Non sono queste le figure sociali che oggi, con forse inutile nuovismo, chiamiamo stakeholder?
Certo, nelle pieghe del bilancio di esercizio si può nascondere l’omissione e l’inganno. Ma altrettanto può accadere, con più facilità, con il bilancio sociale. E certo, il bilancio di esercizio è difficile da leggere. Ma piuttosto che costruire un nuovo strumento, ugualmente non facile da leggere, non sarebbe meglio lavorare per diffondere tra i dipendenti, i fornitori, i clienti, i finanziatori, il pubblico in generale la capacità di leggere veramente il bilancio di esercizio?
La prima verifica della qualità etica di una organizzazione sta, probabilmente, nella trasparenza della sua informazione. Ora, credo che la trasparenza stia molto più nel redigere un bilancio di esercizio veramente completo e leggibile che nel redigere, oltre al bilancio di esercizio (considerato una fastidiosa necessità), un bilancio sociale nel quale ci si racconta come ci pare, confrontandoci con parametri scelti da noi stessi, spesso generici e fumosi e scarsamente vincolanti.
Il problema non sta negli strumenti, e –in fondo– nessun nuovo strumento è necessario neanche per quel che riguarda i Codici di comportamento e le Carte dei valori. Sentirsi dire che l’organizzazione pubblica o privata, orientata o no al profitto “si ispira alla tutela dei diritti umani, del lavoro, della sicurezza, dell’ambiente, nonché al sistema di valori e principi in materia di trasparenza e probità, efficienza energetica, sviluppo sostenibile, così come affermati dalle Istituzioni e dalle Convenzioni Internazionali” è acqua fresca.
Ogni organizzazione possiede un proprio apparato di normative e procedure. Non servono nuovi documenti chiamati in modo nuovo. Servono norme e procedure rispettose dell’etica, e redatte in modo comprensibile.
Questo è particolarmente vero per l’ente del quale parla Viviani nel suo articolo. La Regione emana leggi. Il Codice Etico vale e serve se si inserisce organicamente nel sistema normativo regionale. E più del Codice Etico, conta che tutta la produzione normativa di una Regione, ai diversi livelli di gerarchia delle fonti, sia veramente orientata a trovare un equilibrio etico tra i diversi interessi.
Avevo quasi dimenticato di avere scritto queste pagine. Che avrebbero potuto anche entrare nel testo di Contro il management. E che comunque ne costituiscono una significativa anticipazione – in particolare per alcuni dei temi trattati: la compresenza dei diversi stakeholder, l'etica degli affari (o business ethics che dir si voglia), la Corporate Social Responsibility, la centralità e i limiti delle rilevazioni contabili e bilancistiche, le metriche e gli asset intangibili.
Sono passati sei anni. Mi ritrovo in quello che ho scritto, salvo su un punto. In conclusione critico Bilanci Sociali, Carte dei valori, e in genere tutte le nuove metriche, oggi tanto di moda, tese a descrivere la qualità etica dell'impresa. Affermo quindi che è meglio restare sul concreto e lavorare intanto per rendere più trasparenti e completi i tradizionali 'bilanci d'esercizio' fondati sulla rilevazione contabile.
Confermo la critica di nuovi strumento e nuove metriche. Ma sono diventato più scettico e guardingo al riguardo del bilancio d'esercizio. Come scrivo in Contro il management: il bilancio, lungi dall'incamminarsi verso l'esssere uno strumento descrittivo rispettoso della complessa realtà dell'impresa, è lo strumento, direi quasi il grimaldello, attraverso il quale un solo stakeholder -la finanza nellesue diverse manifestazioni: banca, investitori istituzionali, borsa- subordina l'impresa al suo comando. Insomma: il bilancio potrebbe essere sì equanime, ma in realtà è redatto per dire dell'azienda solo ciò che la finanza vuol sentirsi dire.
Immaginate un edificio abbellito da accattivanti insegne sulla facciata e da bandiere sventolanti sul tetto. Immaginate che questo lussuoso apparato comunicativo sia ostentato come significativa miglioria. Eppure chi vive nell’edificio sa –o dovrebbe sapere– che le fondamenta sono poco solide, e che i sotterranei sono infestati da topi, e sono anche luogo di turpi commerci.
Comunicazione, sovrastruttura, operazione di immagine meramente descrittiva. Questo è, non di rado, il ‘bilancio sociale’, e nel complesso tutta l’impalcatura degli strumenti della Corporate Social Responsibility, CSR (o Responsabilità sociale d’impresa, RSI).
Perché se ne parla tanto, e vi si investono risorse, distogliendole dalla gestione e da azioni orientate al cambiamento, al miglioramento, allo sviluppo? Tutto nasce dal bisogno, diremmo addirittura dalla fame di etica.
La morale non è, in origine, necessaria. E’ del tutto fondato lo scetticismo di chi si domanda ‘perché devo essere morale se l’immoralità consente ad altri di ottenere a buon mercato successo e felicità?’. Trasimaco nella Repubblica di Platone sostiene che l’ingiustizia è più utile della giustizia per chi ha la forza di imporsi agli altri, e che perciò non ha nessun obbligo di seguire le norme che gli impediscono di fare quello che vuole.
Ma la ‘morale’ viene di attualità quando diventa diffusa la percezione del superamento di un limite. Quando si percepisce come eccessiva la sperequazione, la disuguaglianza. Quando è vessata e violata la nostra personale dignità morale, o quella del gruppo cui apparteniamo, o quella di altri a cui riconosciamo la nostra stessa dignità. Quando l’uso della libertà da parte di pochi è uno schiaffo troppo sonoro sul volto di molti. Quando il divario nella distribuzione della ricchezza sfugge al controllo. Quando l’equilibrio dei diritti e delle opportunità appare violato. Quando l’uso delle risorse naturali e lo sfruttamento dell’ambiente rischiano di mettere in discussione il nostro futuro.
Insomma, quando la morale stabilita in una comunità appare, in maniera offensiva, finalizzata solo agli interessi di chi nella comunità stessa detiene il potere, allora emerge il bisogno di un nuovo punto di incontro tra le diverse personali, utilitaristiche, ‘morali’. Allora si manifesta il bisogno di una ‘scienza della morale’, di un’etica.
E’ abbastanza evidente che ci troviamo oggi proprio in questa situazione. Di qui l’attenzione alla ‘sostenibilità’, alla ‘Corporate Governance’, di qui l’accanito dibattito attorno al concetto di stakeholder. Di qui la gran attenzione dedicata alla Corporate Social Responsibility.
Di fronte a tutto questo ciò che desta meraviglia, e che un po’ preoccupa, non è tanto la sostanza –la carenza di etica è un dato di realtà, il bisogno di ‘fare qualcosa’ è perfettamente fondato–. Ciò che meraviglia e preoccupa è l’enfasi del nuovo. C’è tutto il motivo per interrogarsi di nuovo, per rileggere Platone e Aritotele e i Padri della Chiesa e Hobbes e Bentham, Kant, Hobbes, Kant, Rousseau, Fichte, Nietzche, Jaspers, Bonhoeffer e Rawls, e anche magari qualche pagina di Drucker. Si potrebbe riprendere in mano la riflessione sulle regole della convivenza, sul controllo e sul contratto sociale, ed anche sulla teoria pura del diritto e sulle diverse genesi dei patti costituzionali.
Ma invece, salvo qualche dotta citazione, si tende piuttosto a prendere come fondamento qualche recente generico ‘documento ufficiale’, come il Green Paper sulla CSR della Commissione Europea (luglio 2001). E si pretende di trovare le risposte in qualche standard: si pensi in Italia al Progetto Q-RES. Come se l’insoddisfazione morale di fronte al funzionamento delle organizzazioni, e quindi il bisogno di etica, potessero essere risolti sul piano della certificazione. Come se l’etica potesse essere imposta, o garantita, attraverso una norma ISO 9000, 9001 o 9004 che sia.
Di fronte a questo approccio, ben venga la cautela espressa da Mario Viviani. Ma forse c’è da dire qualcosa a voce più alta.
Il problema non sta negli strumenti. E anzi nuovi strumenti rischiano di portare confusione e di favorire soluzioni illusorie. Buone per la ‘società dello spettacolo’, ma lontane alla capacità di incidere sui reali meccanismi del potere e sul reale funzionamento delle organizzazioni. Comunque la si giri il ‘bilancio sociale’ resta uno strumento di secondo livello, una riorganizzazione di informazioni costruita innanzitutto in funzione della facilità di lettura e dell’efficacia comunicativa. E’, al limite, una forma di advertising non tradizionale, vale quanto una sponsorizzazione sportiva o una televendita, o una donazione. Visto che è anche una impalcatura costosa, esistono alternative? Garantisce rispetto allo scopo primario, mettere in luce l’atteggiamento etico dell’organizzazione? Non offre magari dei pericolosi alibi?
Il problema non sta negli strumenti, perché forse gli strumenti esistono già. Il ‘bilancio sociale’ si propone come documento di sintesi, documento che riepiloga i dati più significativi emersi dalla gestione, e che permette di misurare lo scostamento tra l’effettiva gestione e la ‘buona gestione’. Si cerca di affermare il ‘bilancio sociale’ come strumento adatto per ogni persona giuridica, aziende a scopo di lucro, organizzazioni non profit, enti pubblici, lo stesso Stato. Pensate ora a quello strumento di rilevazione che è il bilancio di esercizio. Uno strumento criticabile fin che si vuole. Ma in grado di offrire una sintesi, di riepilogare i dati più significativi emersi dalla gestione, utile per misurare lo scostamento tra l’effettiva gestione e la ‘buona gestione’.E in uso da cinquecento anni, adottato in tutto il mondo, regolato da norme, in grado di permettere confronti.
Perché allora, invece di inventare un nuovo strumento, perché –se si cerca uno strumento in grado di valutare l’etica di una organizzazione– non lavorare a migliorare il ‘bilancio di esercizio’? Se si deve lavorare ad imporre nuovi standard, ben più importante della definizione degli standard di secondo livello tipici del ‘bilancio sociale’ è l’individuazione di parametri attraverso i quali portare alla luce, e a valore, gli asset intantagibili. I brand, gli investimenti in ricerca e sviluppo, le conoscenze detenute da dipendenti e collaboratori, la fidelizzazione dei clienti.
Del resto, si sa che nel bilancio di esercizio fondamentale è la funzione informativa nei confronti delle parti interessante al buon andamento dell'azienda: i dipendenti, i fornitori, i clienti, i finanziatori, il pubblico in generale. Non sono queste le figure sociali che oggi, con forse inutile nuovismo, chiamiamo stakeholder?
Certo, nelle pieghe del bilancio di esercizio si può nascondere l’omissione e l’inganno. Ma altrettanto può accadere, con più facilità, con il bilancio sociale. E certo, il bilancio di esercizio è difficile da leggere. Ma piuttosto che costruire un nuovo strumento, ugualmente non facile da leggere, non sarebbe meglio lavorare per diffondere tra i dipendenti, i fornitori, i clienti, i finanziatori, il pubblico in generale la capacità di leggere veramente il bilancio di esercizio?
La prima verifica della qualità etica di una organizzazione sta, probabilmente, nella trasparenza della sua informazione. Ora, credo che la trasparenza stia molto più nel redigere un bilancio di esercizio veramente completo e leggibile che nel redigere, oltre al bilancio di esercizio (considerato una fastidiosa necessità), un bilancio sociale nel quale ci si racconta come ci pare, confrontandoci con parametri scelti da noi stessi, spesso generici e fumosi e scarsamente vincolanti.
Il problema non sta negli strumenti, e –in fondo– nessun nuovo strumento è necessario neanche per quel che riguarda i Codici di comportamento e le Carte dei valori. Sentirsi dire che l’organizzazione pubblica o privata, orientata o no al profitto “si ispira alla tutela dei diritti umani, del lavoro, della sicurezza, dell’ambiente, nonché al sistema di valori e principi in materia di trasparenza e probità, efficienza energetica, sviluppo sostenibile, così come affermati dalle Istituzioni e dalle Convenzioni Internazionali” è acqua fresca.
Ogni organizzazione possiede un proprio apparato di normative e procedure. Non servono nuovi documenti chiamati in modo nuovo. Servono norme e procedure rispettose dell’etica, e redatte in modo comprensibile.
Questo è particolarmente vero per l’ente del quale parla Viviani nel suo articolo. La Regione emana leggi. Il Codice Etico vale e serve se si inserisce organicamente nel sistema normativo regionale. E più del Codice Etico, conta che tutta la produzione normativa di una Regione, ai diversi livelli di gerarchia delle fonti, sia veramente orientata a trovare un equilibrio etico tra i diversi interessi.
Iscriviti a:
Post (Atom)